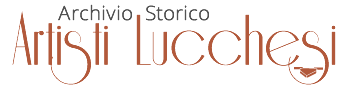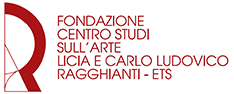Bonetti Uberto stampa la scheda 
Viareggio (Lucca), 31/01/1909

| Cognome | Bonetti |
|---|---|
| Nome | Uberto |
| Luogo di nascita | Viareggio (Lucca) |
| Data di nascita | 31/01/1909 |
| Luogo di morte | Viareggio (Lucca) |
| Data di morte | 10/04/1993 |
| Pittore | 
|
| Scultore | 
|
| Incisore | 
|
| Decoratore | 
|
Biografia
Nasce a Viareggio il 31 gennaio 1909. Il padre Pietro, originario di Pistoia, è impiegato alla dogana, mentre la madre, Emilia Giannessi, è casalinga. Uberto è il maggiore di sette figli. Mostra una precoce inclinazione artistica e nel 1922-23 inizia a frequentare L'Istituto di Belle Arti di Lucca, allievo di Lorenzo Viani, di cui diviene intimo amico nonostante la differenza di età e grazie al quale ottiene un sussidio economico per continuare gli studi. A Lucca, ancora studente, lavora in qualità di disegnatore per alcuni tra i maggiori architetti, scultori e decoratori del periodo. Nel 1926 partecipa al concorso per il manifesto del Carnevale di Viareggio, edizione vinta da Lucio Venna, con il quale inizia una collaborazione. Nel 1929, anche se non ufficialmente, è insieme a Mario Guido Dal Monte fra i decoratori della festa chiamata “Ballo degli Immortali”, che si tiene al Kursaal di Viareggio. Nell'ambiente viareggino conosce molti personaggi celebri tra i quali Luigi Pirandello, Filippo Tommaso Marinetti, Primo Conti ed anche molti uomini politici, di cui esegue caricature. Si dedica alla grafica pubblicitaria e le sue vignette satiriche vengono pubblicate su alcuni dei giornali più importanti d’Italia, come "La Lettura", "Il Telegrafo" e "Il Corriere della Sera". Nello stesso periodo inizia a lavorare al Premio Viareggio e ad occuparsi di moda. Intorno al 1928, una volta ottenuto il diploma di capo mastro, sviluppa una serie di studi sulle maschere della Commedia dell’Arte che porteranno alla creazione, nel 1930, del Burlamacco, maschera-simbolo del Carnevale di Viareggio, caratterizzata da evidenti rimandi all'arte di Depero e Legèr. Dal 1928 sperimenta l’ebbrezza del volo decollando dall’idroporto di Torre del Lago, esperienza che ripete anche presso i campi di volo di Viareggio e Pisa e che lo avvicina alle ricerche avanguardistiche; aderisce infatti alla seconda ondata del futurismo, nota come aerofuturismo. Conosce Krimer, anche lui aviatore, oltre che artista ed operatore culturale del Regime, per il quale realizza le copertine di alcuni libri. A Forte dei Marmi entra in contatto con Curzio Malaparte per il quale eseguirà, su precise indicazioni dello stesso, i disegni architettonici per la villa di Capri, di proprietà dello scrittore. Continua la sua indagine sul costume e la moda e stringe amicizia con Thayaht. Dal 1932 circa inizia a lavorare presso gli stabilimenti cinematografici Pisorno a Tirrenia come architetto di scena. Viaggia molto ed estende le sue attività dal campo della pittura a quello della grafica, dall'architettura all'allestimento per manifestazioni temporanee, dalla moda al design. Nel 1933 realizza il Manifesto ufficiale per le festività di S. Croce a Lucca. Nel 1934 intraprende un primo viaggio in Trentino Alto Adige, interessandosi soprattutto alle nuove costruzioni volute dal regime fascista, creando una serie di "Aeroviste"; due anni dopo effettua un secondo viaggio finalizzato prevalentemente alle sue ricerche sulla moda. Nell'inverno 1936–1937 compie un lungo giro in Sardegna con l’amico Thayaht, Anche questo motivato dallo studio degli abiti e dei costumi tradizionali sardi. Espone in mostre futuriste e diviene il "mise-en-scene" del Carnevale di Viareggio. Nel 1942 parte per l’Albania per compiere una serie di sopralluoghi finalizzati alla realizzazione del film Scanderberg, l’aquila di Albania. Rientra in Italia in precarie condizioni di salute. Nel periodo bellico diventa partigiano, viene catturato e fatto prigioniero a Bologna, ma riesce a sfuggire alla deportazione. Durante un bombardamento degli alleati, il suo studio a Viareggio è distrutto e con esso gran parte dell’opera grafica e pittorica. Nel dopoguerra, malato e con un acuto esaurimento nervoso, continua comunque a lavorare per il Carnevale e anche per il Premio letterario Viareggio. Conosce e frequenta scrittori ed intellettuali: da Riccardo Bacchelli ad Alberto Moravia, da Elsa Morante a Cesare Zavattini, da Eugenio Montale a Pier Paolo Pasolini. Negli anni Cinquanta del Novecento si sposa con Paolina Polini, dalla quale ha due figlie. Espone sempre più raramente, ma intensifica la sua attività come allestitore e grafico. Declina un invito a recarsi ad Hollywood per realizzare cartoni animati per la Warner Bros. Continua a lavorare nel cinema sino agli inizi degli anni Sessanta, quando lo abbandona per l’insegnamento, prima all'Istituto Tecnico per Geometri di Lucca (1957-75), poi all'Istituto d’Arte di Pietrasanta, ed infine a quello di Faenza. Negli anni Settanta torna ad esporre con grande successo a Milano, Firenze, Pistoia e, naturalmente, a Viareggio, dove nel 1993 viene inaugurata un'importante antologica a Palazzo Paolina. Muore nella città natale pochi giorni dopo la chiusura della mostra, il 10 aprile 1993.
Della donazione Bonetti, conservata presso la Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani di Viareggio, esiste un catalogo-inventario a cura di Claudio Giorgetti, Barbara Ciomei e Adriana Bonetti, riportato in bibliografia. Tra i contributi bibliografici segnaliamo il volume stampato i occasione dell'antologica a Palazzo Paolina: Il taccuino di Burlamacco: racconto per immagini della creazione dell'ultima nata tra le Maschere italiane ed altre opere 1929-1992, Pistoia, Studio Kronos, 1992.