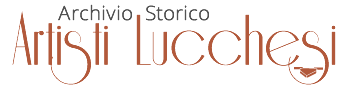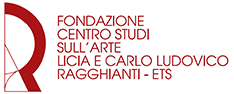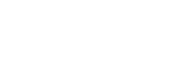Norfini Luigi stampa la scheda 
Pescia, 01/06/1825
| Cognome | Norfini |
|---|---|
| Nome | Luigi |
| Luogo di nascita | Pescia |
| Data di nascita | 01/06/1825 |
| Luogo di morte | Lucca |
| Data di morte | 22/04/1909 |
| Pittore | 
|
| Scultore | 
|
| Incisore | 
|
| Decoratore | 
|
Biografia
Nacque il 1 giugno 1825 a Pescia, allora facente parte del Ducato di Lucca, da Giuseppe, docente di ostetricia, e da Elisabetta Bartoli. Dopo gli studi presso le pie Scuole fiorentine dei padri scolopi (vi risulta iscritto nel 1834), proseguì la sua formazione all’Accademia di Belle Arti di Firenze (1841), sotto la direzione di Giuseppe Bezzuoli, ed ebbe come compagni di studi Carlo Ademollo, Cosimo Conti e Annibale Gatti. Nel 1848 si iscrisse alla scuola di indirizzo purista di Luigi Mussini e di Adolphe Von Stürler. Lo stesso anno si arruolò come volontario, insieme al fratello Alessandro, nella prima guerra d’Indipendenza e partecipò alla battaglia di Curtatone, non mancando di eseguire, nei rari momenti liberi, ritratti e schizzi dei suoi commilitoni. Tornato a Firenze riprese gli studi artistici, orientandosi verso la pittura di storia e il ritratto. Aprì il proprio studio nei locali delle scuderie reali e frequentò al Caffè Michelangiolo i protagonisti dell’avanguardia toscana, stringendo inoltre amicizia con Stefano Ussi, Angiolo Tricca, Antonio Ciseri e lo scrittore Carlo Collodi. Partecipò con regolarità alle esposizioni annuali presso l’Accademia fiorentina, affrontando anche soggetti religiosi. Nel 1849 dipinse il bozzetto raffigurante La ritirata di Curtatone, (attualmente conservato presso il Museo Nazionale di Palazzo Mansi di Lucca), esposto all'Accademia fiorentina l’anno successivo. A Torino, nel 1849, entrò in contatto con Massimo D’Azeglio e Camillo Benso conte di Cavour. L’amicizia con il generale Carlo Felice Di Robilant fu fondamentale per far conoscere la sua opera presso la Corte Reale. Nel 1859 dipinse, su incarico del Governo provvisorio di Toscana, “La battaglia di Novara”. Nello stesso anno il dipinto fu esposto alla mostra nel Palazzo di Brera a Milano, acquistato dal primo ministro Bettino Ricasoli e donato a Vittorio Emanuele II per la Galleria di battaglie in Palazzo Reale a Milano. Il 23 settembre 1859 partecipò a un concorso (bandito dal Governo Toscano su iniziativa dello stesso Ricasoli) con lo scopo di coinvolgere gli artisti alla causa dell’unificazione d’Italia, ottenendo il secondo premio con un quadro di azione militare. Il Sovrano gli commissionò due opere di soggetto militare, presentate all’Esposizione generale italiana di Torino del 1884: la “Battaglia di Palestro” (1863), e la “Battaglia di S. Martino” (1874). Nel 1875 quest’ultimo dipinto, che ottenne l’ammirazione dei pittori francesi Ernest Jean-Louis-Meissonier e Jean-Leon Gérôme, fruttò a Norfini l’invito da parte del sultano a recarsi a Costantinopoli per dipingere quadri di battaglie, in cambio di una cospicua retribuzione. Il pittore rifiutò l’offerta suggerendo il nome dell'amico Ussi, che partì al suo posto. Un particolare dell’opera, intitolato “Veduta della collina di S. Martino”, fu donato al Museo nazionale di Palazzo Mansi a Lucca dove oggi si conserva. Si affermò anche come cronista nei moti risorgimentali (fu inviato alla campagna del 1866) e autore di scene patriottiche dalla forte connotazione apologetica, realizzando inoltre numerosi ritratti di esponenti della nobiltà pesciatina. Nei decenni successivi all’Unità d’Italia, ottenne dalla casa reale importanti riconoscimenti e commissioni. Nel 1863 Vittorio Emanuele II lo nominò cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro, concedendogli nel 1875 una pensione dello stesso ordine, mentre il successore Umberto I gli commissionò, per la sala del trono al Quirinale, il “Ritratto di Vittorio Emanuele II”. Il barone Ricasoli, suo benefattore, nel 1863 lo incaricò di eseguire due opere per ricordare la “Visita di re Vittorio Emanuele II al Castello di Brolio”, nel 1863 e nel 1866 un quadro privato in memoria di sua moglie. Nel 1866 fu nominato professore onorario all’Accademia di Belle Arti di Firenze dove non esercitò mai la professione ma fece parte delle commissioni giudicatrici. Ebbe contatti con gli artisti e gli studenti lucchesi che in quegli anni lavoravano o svolgevano il perfezionamento nella capitale d’Italia, fra cui Augusto Passaglia, Lionello De Nobili, Michele Marcucci e, infine, Enrico Ridolfi, al quale Norfini fu legato da un costante rapporto epistolare. Nel 1875, morto Sebastiano Onestini, Norfini gli subentrò nell’ufficio di direttore dell’Istituto di Belle Arti di Lucca, che guidò fino al 1897, ricoprendo inoltre la cattedra di Disegno superiore della figura e quella di Pittura. Sotto la sua direzione si formarono, Cipriano Cei, Luigi De Servi, Giorgio Lucchesi, oltre ai figli Giuseppe, Alfredo e Mario. Nel 1876 supplì gratuitamente Giuseppe Marcucci (andato in pensione), nella cattedra di Disegno elementare della figura. Fu promotore di cultura e di eventi celebrativi dell’unità d’Italia e della storia di Lucca. Dal 1872 fu presidente della Commissione delle belle arti e ideatore dell’Esposizione d’arte antica del 1877. Due anni dopo fu chiamato a far parte della commissione per la collocazione della statua in memoria di Vittorio Emanuele II, opera di Augusto Passaglia. Nel 1882 ottenne la nomina a direttore della Pinacoteca Civica di Lucca, inaugurata nel 1875, e nel 1883, su incarico dal ministero della Pubblica Istruzione, fece parte della giuria per l’Esposizione d’arte di Monaco di Baviera. Nel 1890, fautore di un’ornamentazione di gusto neo-cinquecentesco, fu membro della commissione esaminatrice dei bozzetti per la decorazione del cimitero monumentale di Lucca. Gli impegni professionali non gli impedirono di continuare l’attività pittorica ed espositiva soprattutto in ambito locale. Nel 1897 Norfini, a causa di una malattia agli occhi, dovette sospendere la docenza all’Istituto di Belle Arti di Lucca. La cattedra di disegno superiore della figura e di pittura fu temporaneamente affidata a Michele Marcucci che, su incarico del Ministero, assunse anche la direzione provvisoria dell’Istituto fino al 1900. Sposò, in prime nozze, la nobildonna fiorentina Eugenia Orlandi Cardini, da cui ebbe sette figli, tre dei quali seguirono, fin dall’infanzia, le orme del padre, affascinati dalla sua forte personalità. Morì a Lucca il 21 aprile 1909.
Tra i contributi bibliografici segnaliamo il lemma redatto da Alessandra Nannini, Luigi Norfini, in "Dizionario Biografico degli Italiani", volume 2013, risorsa consultabile on-line.
Luoghi di formazione
| Anno inizio | Anno fine | Nazione | Città | Istituzioni | Periodo certo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 1848 | Italia | Firenze | Accademia di Belle Arti di Firenze. | Si | |
Maestri:
| ||||||
| Incontri: | ||||||
Luoghi di attività
| Anno inizio | Anno fine | Nazione | Città | Luogo | Periodo certo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | 1909 | Italia | Firenze | Accademia di Belle Arti Firenze | Si |
| 1875 | 1897 | Italia | Lucca | Istituto di Belle Arti | Si |
| 1882 | 1887 | Italia | Lucca | Regia Pinacoteca | Si |
Opere

Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi
Oggetto: dipinto
Soggetto: alcova con cameriere in livrea
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 105 x 140
Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi
Oggetto: dipinto
Soggetto: ritratto
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 103 x 79
Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi
Oggetto: dipinto
Soggetto: ritratto
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 230 x 155
Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi
Anno produzione: 1849
Luogo attuale: Milano, Palazzo Reale
Oggetto: dipinto
Soggetto: di genere
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 293 x 486
Luogo attuale: Milano, Palazzo Reale

Anno produzione: 1850
Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi
Oggetto: dipinto
Soggetto: storico
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 48 x 85
Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Anno produzione: 1859
Luogo attuale: Solferino (Mantova), Società Solferino e San Martino. Museo della Battaglia di Solferino
Oggetto: disegno
Soggetto: figura maschile di zuavo
Tecnica: inchiostro a china su carta
Misure: mm 205 x 307
Luogo attuale: Solferino (Mantova), Società Solferino e San Martino. Museo della Battaglia di Solferino
Anno produzione: 1874
Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi
Oggetto: dipinto
Soggetto: paesaggio
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 45 x 110
Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi

Anno produzione: 1884
Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi
Oggetto: dipinto
Soggetto: storico
Tecnica: olio su tela
Misure: cm 285 x 225
Luogo attuale: Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi
Esposizioni
| Anno | Titolo | Luogo | Città | Nazione |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | Esposizione Permanente dell'Associazione Artisti Italiani | Sede di Via de' Bardi | Firenze | Italia |
Bibliografia
Manoscritti
| Anno | Titolo | Tipologia | Archivio | Fondo | Filza |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lettere di L. Norfini | Carteggio | B.S.L. | Carteggio E. Ridolfi | 3647 |
| 0 | Ruolo degli Accademici | A.S.F. | Arch. Accad. Prof. di prima classe Reg. | N.1 | |
| 1864 | Pitture al cimitero urbano | A.S.C.L. | Busta n. 41 | ||
| 1893 | Belle Arti in Lucca dal 753 al presente | Compendio Biografico | A.S.L. | Legato Cerù | Ms. 193/194 |
Libri
| Anno | Titolo | Autore | Editore | Città |
|---|---|---|---|---|
| 1831 | Saggio di monumenti simbolici ed allegorici antichi e moderni esistenti a Firenze | G. Del Rosso | Opuscolo presso Sebastiano Nistri | Pisa |
| 1875 | Conte Finocchietti (Maestro di Cerimonie di Corte) 3 ottobre 1875 | |||
| 1875 | Scritto sulla Battaglia di S. Martino, 20 settembre 1875 | G. Dini (Maestro di Cerimonie) | ||
| 1889 | Dizionario deghli artisti italiani viventi: pittori, scultori, architetti. | A. De Goubernatis | Le Monnier | Firenze |
| 1892 | Dizionario degli artisti italiani viventi | A. De Gubernatis | Firenze | |
| 1925 | Luigi Norfini artista e uomo | Municipio di Pescia | Pescia | |
| 1933 | Dizionario del Risorgimento. Biografia dell'artista a cura di E. Michel | M. Rosi | Vallardi | Milano |
| 1934 | Kunstlerlex, XXVIII | Thieme, U. e Becker, F. | ||
| 1940 | L'Istituto d'Arte "A. Passaglia" | E. Lazzareschi | Istituto d'Arte "A. Passaglia" | Lucca |
| 1945 | Dizionario illustrato dei pitttori, disegnatori e incisori italiani moderni e contemporanei | A. M. Comanducci | Grafitalia | Milano |
| 1950 | Un pittore alle guerre del Risorgimento: Luigi Norfini da Pescia | Gino Arrighi | Tip. Alberto Pacinotti | Pistoia |
| 1973 | Dizionario illustrato dei pittori e incisori italiani Moderni e contemporanei | A. M. Comanducci | Luigi Patucci | Milano |
| 1989 | Lucca, Pisa, Livorno e province negli articoli e nelle cronache di "Arte e Storia" (1882-1916). Studi e Documenti per la Storia della Toscana – N.1. | D.I. e A.G. | Editrice Izzo | Lucca |
| 1995 | Aspetti del mondo culturale lucchese tra la fine dell'| G. Lera |
Arte della Stampa |
Lucca |
|
| 2013 | Norfini, Luigi, in Dizionario Biografico degli Italiani | Alessandra Nannini | Istituto dell'Encicolopedia Italiana Treccani | Roma |
Riviste
| Anno | Titolo | Numero | Edizione | Titolo rivista | Città |
|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | Nostri artisti contemporanei: Luigi Norfini – Eurisio Capocci – Giorgio Lucchesi | 10 luglio 1882, pp. 54-55 | 1882 | Arte e Storia | Firenze |
| 1884 | Da Lucca, un quadro del Prof. Luigi Norfini | Lucca 24 marzo 1884, p.102. | 1884 | Arte e Storia | Firenze |
| 1887 | Un artista di belle speranze | Anno I, N.4 | 1887 | L’Esare | |
| 1889 | Lucca. Una lapide [Il Prof. Norfini in occasione della festa per la distribuzione dei premi inaugurò una lapide che ricorda una moderna gloria di Lucca e dell’Istituto, il Prof. Augusto Passaglia] | 1889 | Arte e Storia | ||
| 1889 | Un ritratto di Sua Maestà il Re | N. VIII, p. 112 | 1889 | Arte e Storia | |
| 1893 | Il Monumento a Matteo Civitali, inaugurato in Lucca il 17 settembre e la festa artistica di cui fu motivo | pp.169-170 | 1893 | Arte e Storia | |
| 1894 | Curtatone-Montanara | 29 maggio 1894 | 0 | il Don Chichiotte di Roma |
Cataloghi
| Anno | Titolo | Editore | Città |
|---|---|---|---|
| 2001 | Luigi De Servi (1863-1945). Ritratto d'artista | Maschietto & Musolino | Pistoia |
Giornali
| Data | Titolo giornale | Autore articolo | Titolo articolo |
|---|---|---|---|
| 24-05-1909 | Il Corriere della Sera | ||
| 9-07-1960 | Giornale del Mattino | Gino Arrighi | In ricordo del pittore Luigi Norfini |