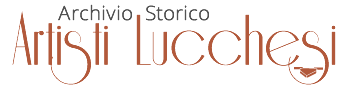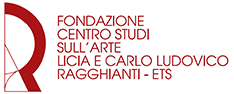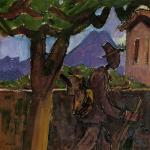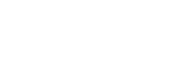Magri Alberto stampa la scheda 
Fauglia (Pisa), 04/06/1880
| Cognome | Magri |
|---|---|
| Nome | Alberto |
| Luogo di nascita | Fauglia (Pisa) |
| Data di nascita | 04/06/1880 |
| Luogo di morte | Barga (Lucca) |
| Data di morte | 25/02/1939 |
| Pittore | 
|
| Scultore | 
|
| Incisore | 
|
| Decoratore | 
|
Biografia
Nacque a Fauglia, in provincia di Pisa, il 4 giugno 1880. I genitori, Giovanni e Emma Salvi, appartenevano entrambi a famiglie borghesi di Barga. La famiglia Magri si era trasferita a Fauglia per seguire il capofamiglia, che vi ricopriva l'incarico di pretore, non cessando però di fare ritorno, durante le vacanze estive, al paese d'origine. Nel 1899 il giovane Alberto si iscrisse dapprima alla facoltà di Scienze naturali e quindi a quella di Chimica e farmacia, con mediocri risultati. Iniziò ben presto a mostrare un grande talento per le arti figurative e le sue caricature apparvero su giornali goliardici come «Il Gobbo di Picche» e «L'abbozzo». Inevitabile fu dunque il viaggio a Parigi, dove tra il 1902 e il 1903 lavorò per molti giornali umoristici, tra cui "Le Journal", "La caricature", "La vie pour rire". Rientrato in Italia, nel dicembre 1907 ottenne la laurea e si trasferì a Firenze, dove iniziò l'attività di farmacista, pur mantenendo il collegamento con il paese d'origine, con l'ambiente pascoliano e con lo scultore Leonardo Bistolfi (a Barga per la realizzazione del monumento funebre a Giovanni Pascoli), che si interessò alla sua opera e ne caldeggiò l'inserimento nell'elenco dei soci artisti della Corporazione degli Xilografi. In questo periodo dipinse una serie di piccole tempere su tavola, dove il segno si fissa immutabilmente a definire un gesto o uno stato psicologico, in un clima sottilmente arcaizzante. Opere note di questo periodo sono il "Trittico della Vita campestre" e "La casa in ordine - La casa in disordine", successivamente smembrata in tante piccole parti dallo stesso artista. Nel 1914 espose a Firenze, al Lyceum. Nel 1915 si affaccia il tema quasi autobiografico del Cantastorie, mentre anche il linguaggio risente di esperienze più moderne, che vanno dal cubismo al contatto fraterno con Viani. Il 1916 è ancora un anno importante, con la mostra milanese alla "Famiglia Artistica", per cui disegna i due cartoni esposti all'ingresso dell'invito-manifesto. Terminata la guerra si trasferì ad Intra, sul Lago Maggiore, svolgendo la professione di insegnante di Scienze all'Istituto Commerciale, ma nell'estate del 1919 rientrò definitivamente a Barga. Fu insegnante elementare, poi farmacista, infine dal 1925 direttore dell'agenzia del Monte dei Paschi. Nel 1922 si era sposato con Elba Carradini, anche lei appartenente ad una delle famiglie più importanti del paese, e nel 1924 era nato il figlio Giovanni. Magri fu riluttante alle sollecitazioni esterne tanto che non partecipò alla prima "Mostra del Novecento italiano", inaugurata da Mussolini a Milano nel 1926, ma anche la presenza in ambito locale fu limitata (espose alla prima e seconda mostra d'arte barghigiana, nel 1925 e nel 1929). Nel 1927 partecipò alla Biennale con il dittico "La sementa nella valle del Serchio", nel 1929 alla seconda Mostra del Novecento Italiano a Milano con il dipinto "Crepuscolo invernale", nel 1934 vinse in ex aequo con Alfredo Meschi la III edizione del Premio Caselli (commissione composta da Ezio Ricci, Lorenzo Viani e Bruno Cordati) con l'opera "Cantastorie in Piazza Garibaldi" e nel 1937 espose al Kursaal di Viareggio tre capitoli del "Diario del Cantastorie". Visse quasi sempre a Barga, in solitudine, dove morì nel 1939. Nel 1951 "La Strozzina" di Firenze gli ha reso omaggio con una mostra postuma di 50 opere.
Il suo archivio personale è tra i fondi censiti all'interno del progetto "Archivi di personalità" del SIUSA. Tra i contributi bibliografici a lui dedicati segnaliamo in particolare il catalogo Alberto Magri: un pittore del '900, a cura di Gianfranco Bruno e Umberto Sereni, Firenze, Artificio, 1996.
Luoghi di formazione
| Anno inizio | Anno fine | Nazione | Città | Istituzioni | Periodo certo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 1907 | Italia | Pisa | Facoltà di Scienze Naturali, Facoltà di Chimica e Farmacia. | Si |
Luoghi di attività
| Anno inizio | Anno fine | Nazione | Città | Luogo | Periodo certo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 1903 | Francia | Parigi | Si | |
| 1919 | 1939 | Italia | Barga (Lucca) | Si | |
Opere

Anno produzione: 1912
Luogo attuale: Collezione privata
Oggetto: dipinto
Soggetto: di genere
Tecnica: olio su tavola
Misure: cm 75 x 326
Luogo attuale: Collezione privata

Anno produzione: 1912
Luogo attuale: Collezione privata
Oggetto: dipinto
Soggetto: di genere
Tecnica: olio su tavola
Misure: cm 75 x 326
Luogo attuale: Collezione privata

Anno produzione: 1912
Luogo attuale: Collezione privata
Oggetto: dipinto
Soggetto: di genere
Tecnica: Tempera su tavola
Misure: cm 46 x 185
Luogo attuale: Collezione privata
Anno produzione: 1916
Luogo attuale: Torino, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea
Oggetto: dipinto
Soggetto: veduta del molo con figure
Tecnica: Tempera su tavola
Misure: cm 25 x 41
Luogo attuale: Torino, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea

Anno produzione: 1916
Luogo attuale: Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Torino
Oggetto: dipinto
Soggetto: paesaggio
Tecnica: tempera su tavola
Misure: cm 26 x 37
Luogo attuale: Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Torino

Anno produzione: 1916
Luogo attuale: Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Torino
Oggetto: dipinto
Soggetto: veduta di esterno con figura
Tecnica: Tempera su tavola
Misure: cm 26 x 35
Luogo attuale: Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Torino

Anno produzione: 1928
Luogo attuale: Collezione privata
Oggetto: dipinto
Soggetto: di genere
Tecnica: Tempera su tavola
Misure: cm 60 x 180
Luogo attuale: Collezione privata
Anno produzione: 1936
Luogo attuale: Barga, Fondazione Ricci Onlus
Oggetto: dipinto
Soggetto: composizione con figura
Luogo attuale: Barga, Fondazione Ricci Onlus

Anno produzione: 1936
Luogo attuale: Collezione privata
Oggetto: dipinto
Soggetto: di genere
Tecnica: olio su tavola
Misure: cm 50 x 72
Luogo attuale: Collezione privata
Esposizioni
| Anno | Titolo | Luogo | Città | Nazione |
|---|---|---|---|---|
| 1914 | Mostra personale | Lyceum | Firenze | Italia |
| 1916 | Mostra personale | Famiglia Artistica | Milano | Italia |
| 1925 | Prima mostra d'arte barghigiana | Barga (Lucca) | Italia | |
| 1928 | Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia | Giardini della Biennale | Venezia | Italia |
| 1929 | Seconda mostra d'arte barghigiana | Barga (Lucca) | Italia | |
| 1929 | Seconda Mostra del Novecento Italiano | Palazzo della Permanente | Milano | Italia |
| 1929 | Mostra d'Arte della "Settimana Lucchese" | Palazzo Ducale | Lucca | Italia |
| 1931 | Mostra degli Artisti Toscani | Kursaal | Viareggio | Italia |
| 1934 | Premio Caselli | Caffè Caselli | Lucca | Italia |
| 1937 | IV Mostra Estiva Viareggina | Kursaal | Viareggio | Italia |
| 1937 | IV Mostra Sindacale d'Arte | Sede della Confederazione Professionisti e Artisti | Lucca | Italia |
| 1946 | Mostra retrospettiva | Galleria "Il San Michele" | Lucca | Italia |
| 1951 | Mostra retrospettiva | La Strozzina | Firenze | Italia |
| 1965 | Dipinti di maestri contemporanei | Galleria La Piramide | Lucca | Italia |
| 1967 | Arte Moderna in Italia | Palazzo Strozzi | Firenze | Italia |
| 1978 | Arte a Lucca 1900-1945 | Palazzo Mansi | Lucca | Italia |
Bibliografia
Manoscritti
| Anno | Titolo | Tipologia | Archivio | Fondo | Filza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | Artisti Lucchesi | Raccolta di ritagli di giornale | Biblioteca Statale di Lucca | Guido Brancoli |
Libri
| Anno | Titolo | Autore | Editore | Città |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | Artisti Lucchesi | Guido Brancoli | ||
| 1945 | Dizionario illustrato dei pittori, disegnatori e incisori italiani e moderni e contemporanei | A. M. Comanducci | Leonilde M. Patuzzi | Milano |
| 1958 | Artisti toscani del primo Novecento [p. 93] | A. Parronchi | Sansoni | Firenze |
| 1980 | Alberto Magri (1880-1939), tesi di laurea, vol. I-II (catalogo delle opere) | Maria Anna Perrotti | Università degli Studi di Firenze | Firenze |
| 2001 | Contributi per la storia dell'arte lucchese [pp. 205-8] | Giuseppe Ardinghi | M. Pacini Fazzi | Lucca |
| 2002 | Alberto Magri caricaturista | Francesca Sini | Carocci | Roma |
Riviste
| Anno | Titolo | Numero | Edizione | Titolo rivista | Città |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Alberto Magri, pittore barghigiano | 8-9 | 1978 | Notiziario storico, filatelico, numismatico | |
| 8 | Alberto Magri: pittore barghigiano del primo Novecento | 2 | 1980 | Rivista di archeologia, storia, costume | |
| aprile-giugno | Alberto Magri | 2 | 1963 | La Provincia di Lucca | |
| LXIII | Regola, grammatica, sintassi e atto creativo. L'opera di Alberto Magri | 6 | 2000 | Critica d'Arte |
Cataloghi
| Anno | Titolo | Editore | Città |
|---|---|---|---|
| 1972 | Alberto Magri | Galleria d'Arte Moderna Falsetti | Prato |
| 1984 | Alberto Magri | Castello di Volpaia | Radda in Chianti |
| 1984 | Uomini e luoghi del lavoro. Artisti del '900: Viani, Soffici, Magri, Carrà, Sironi, Rosai | Vangelista | Milano |
| 1996 | Alberto Magri. Un pittore del '900, cat. della mostra, Barga, 1996 | Artificio | Firenze |
| 2000 | Pittori italiani in Versilia e Lucchesia | Maschietto & Musolino | Montespertoli |