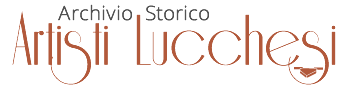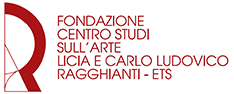Scapecchi Gaetano stampa la scheda 
Lucca, 01/10/1900
| Cognome | Scapecchi |
|---|---|
| Nome | Gaetano |
| Luogo di nascita | Lucca |
| Data di nascita | 01/10/1900 |
| Luogo di morte | Lucca |
| Data di morte | 24/10/1975 |
| Pittore | 
|
| Scultore | 
|
| Incisore | 
|
| Decoratore | 
|
Biografia
Nasce a Lucca il 1 ottobre del 1900, figlio di commercianti, ultimo di tre fratelli. Il padre, Solferino, è titolare di due negozi di stoffe e passamanerie, frequentati da una raffinata e facoltosa clientela, che consente alla famiglia di vivere agiatamente. A seguito della la morte del padre e del successivo fallimento dell’attività commerciale, decide, ancora giovanissimo, di intraprendere la professione di scultore. Compie il proprio apprendistato nello studio del celebre scultore Francesco Petroni, realizzando a partire dal 1919 una notevole produzione in campo funerario e monumentale. Di fatto le prime opere, tra cui alcuni bozzetti ed un bassorilievo dedicato ad Alfredo Catalani, risalgono al 1912-15. Bersagliere a Roma durante il Primo Conflitto Mondiale, nel Dopoguerra si trasferisce nel quartiere di Pelleria, dove nel 1925 esegue una lampada votiva di bronzo ed una targa ai Caduti raffigurante “S. Giorgio e il drago” per l'esterno della Chiesa di S. Tommaso, anch'essa in bronzo, ed incastonata in una grande lapide in stile romanico. Nel 1921 sposa Bianca Marraccini, originaria di S. Lorenzo a Vaccoli, da cui ha un figlio, Francesco, nato l’anno successivo. Trascorre il viaggio di nozze a Viareggio, dove è ospite di Lorenzo Viani. In questo periodo realizza varie opere dedicate ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. Nel 1924 partecipa al concorso per un bassorilievo per il Parco della Rimembranza di Cesena, ottenendo il secondo premio ed una segnalazione sulla stampa locale. Nel 1926 scolpisce una lampada votiva per il Monumento ai Caduti di Vorno; nel 1929 realizza invece una lapide in marmo bianco con un tondo in bronzo raffigurante S. Martino a cavallo per la facciata dell'omonima chiesa in località Migliano, nel comune di Fosciandora, anch'essa dedicata ai Caduti della Grande Guerra. È anche autore dei monumenti ai Caduti di S. Cassiano a Vico, di Mugnano e di Monsagrati, quest'ultimo raffigurante S. Zita. Tutte e tre le opere furono all’epoca oggetto di critiche per la rappresentazione antiretorica e antieroica del soggetto, incentrata sul dramma familiare o sul soggetto sacro piuttosto che sull’iconografia del fante caduto o vittorioso, in gran voga nel periodo. Tra le altre realizzazioni, ricordiamo il Monumento in bronzo al Capitano Giulietti per il Porto di Rimini (1962); la decorazione della Villa Puccini a Viareggio; eseguita in collaborazione con Baccelli, della Hall dell’Hotel Universo a Lucca, realizzata in coppia con il pittore Leone Lorenzetti e risalente agli anni Trenta del Novecento; otto formelle in terracotta per la Chiesa di S. Marco a Lucca, raffiguranti i quattro Evangelisti (S. Marco, S. Matteo, S. Luca e S. Giovanni) e i quattro Dottori delle Epistole (S. Pietro, S. Giacomo, S. Giuda e S. Paolo), inaugurati nel 1964. Nel corso della sua carriera ha inoltre scolpito numerose opere per il Cimitero Urbano di Lucca: il sepolcro di Rosa e Domenico Di Simo, rappresentanti un Cristo alla Colonna e la Madonna addolorata (1929), un'immagine bronzea a bassorilievo del Redentore per la tomba di Igino di Simo (1936); un monumento murale raffigurante un nido infranto con cinque rondinini, che spiccano il volo verso la croce, in marmo bianco di Carrara con cornice in pietra di S. Maria, per la tomba di Amedeo Lazzareschi (1937); una stele in bronzo con cornice in pietra di Matraia, sormontata dal simbolo mariano, per la tomba di Angela Casini nei Biancalana, rappresentante una madre che si congeda dalla sua bambina, e una stele funeraria adorna, nella parte superiore, di una croce con corona di spine per la tomba dei coniugi Tecla e Giuseppe Messori (a cui sarà aggiunto un putto che regge un lampada votiva, opera in seguito trafugata), entrambe risalenti al 1938; il bassorilievo in bronzo del Buon Pastore, inseiro in un’architettura in pietra di Matraia per la tomba di Giovanni Grazioli (1939); il ritratto in bronzo alla memoria di Anita Tonelli nei Severi, inserito in un insieme architettonico in pietra di Matraia (1940); un bassorilievo in bronzo con Cristo benedicente che regge l’olivo racchiusa in una lapide in marmo venato per la tomba di Giuseppe Centoni e un angelo in bronzo per il sepolcro dei coniugi Giovanni e Eugenia Manfredini (1941); il monumento funebre di Anania, Giulietta e Ugo Citti, costituito da un bassorilievo in bronzo con gli Angeli e il Cristo deposto, inquadrato in una struttura in pietra di Matraia (1942); il ritratto in bronzo per la tomba dei coniugi Puccini, genitori di Giacomo, sotto l’arcata destra del cimitero monumentale (1959); i monumenti funebri di Emilio Picchi e Adelaide Piccinini (un bassorilievo in bronzo col torso di Cristo risorto e un’architettura in pietra di Matraia); di Maria Gemma Morelli e Iolanda Rosellini (un angelo in bronzo, risalente al 1949); di Silvio Cagnacci e Rosa Minucciani (architettura angolare in pietra di Matraia nella nicchia cristo risorto in piedi con croce in bronzo); il Cristo Risorto in marmo a grandezza naturale per il sepolcro Martinelli-Lenzi (1925 ca); il tondo in bronzo a bassorilievo raffigurante il Buon pastore per la tomba di Umberto Simonetti, in un’architettura in pietra di Matraia (1952), una bassorilievo in bronzo che rappresenta la famiglia, inserito in una stele in pietra di Matraia con base in bianco per la tomba di Francesco Landucci (1953). Nel settembre 1940 è vittima di un grave incidente: un violento temporale devasta il suo studio, situato nella casermetta San Pietro, a Porta San Jacopo, distruggendo gran parte dei bozzetti e un certo numero di opere (l’atelier dello scultore era in un primo momento situato all’interno di un'antica polveriera, fuori Porta S. Donato, in seguito presso il Baluardo S. Salvatore). Due anni prima aveva invece subito ben due tentativi di furto ad opera di ignoti. Nel periodo tra le due guerre partecipa a varie esposizioni a carattere sindacale, pur non essendo in possesso della tessera del P.N.F., e frequenta il cenacolo culturale che si riunisce al Caffè Di Simo (ex Caselli), formato da Giuseppe Ardinghi, Leone Lorenzetti, Mari Di Vecchio, Carlo Granaiola, Mario Palagi, Domenico Lazzareschi e Guglielmo Petroni. Quest'ultimo così lo ricorda nella sua autobiografia: «Gaetano Scapecchi non era solo uno scultore dalle qualità eccellenti, possedeva già, in quell'angolo di provincia, alcune preziosità plastiche che divennero significative in Martini e Manzù; ma era anche un uomo bonario, un possibile grande amico [..]» (cfr. Il nome delle parole, Milano, Rizzoli, 1984). Nel 1931 espone a Milano, nella Galleria omonima, insieme a Lazzareschi, Ardinghi e Di Vecchio, ottenendo le lodi di Carlo Carrà, che di lui scrive: «volendo dir tutto in una frase, potrei concludere che questo giovine scultore riesce a darci della forma, sia pure parzialmente e frammentariamente vitale, che, sviluppata, potrà essere arte non destinata a naufragare nel breve cerchio delle effimere mode. […] La tendenza realistica è, in questo scultore, più decisa che non nei pittori che lo affiancano» e «non ricorre ad alcun ingrandimento retorico». Nel 1934 partecipa alla XIX edizione della Biennale veneziana; nello stesso anno consegue il III Premio Caselli (con una commissione formata da Italo Griselli, Lorenzo Viani, Mario Carlesi) e il primo premio di incoraggiamento in occasione III Mostra Sindacale di Lucchesia, mentre in precedenza aveva ottenuto quello, ambitissimo, del Duce in occasione della Prima Mostra Nazionale del Sindacato Belle Arti (1933). Nel 1937 gli viene assegnato il 1° Premio Viani per la scultura nell'ambito della IV Mostra Estiva Viareggina, grazie all’opera “La Dormiente”, che può a buon diritto essere annoverata tra i suoi capolavori. Nel 1942 fa parte della giuria di selezione, insieme al pittore Mario Nardi, della XIII Mostra d'Arte Toscana di Palazzo Strozzi, in qualità di membro eletto dagli espositori. Durante la seconda Guerra Mondiale, su precisa indicazione della Soprintendenza, le sue opere in bronzo sono risparmiate dalla fusione, a dimostrazione della considerazione di cui godeva all’epoca lo scultore. Nell'immediato Dopoguerra partecipa attivamente alla vita artistica cittadina, tanto che nel 1949 è protagonista di un acceso dibattito sulla stampa locale per salvare dall'abbattimento gli alberi delle Mura Urbane, in polemica con l'Ing. Di Ricco, responsabile della Commissione Municipale incaricata di soprintendere ai lavori di mantenimento e custodia della cerchia muraria. Nello stesso periodo si ritrova al centro delle polemiche scoppiate in occasione del Premio Lucca 1949, in quanto membro del Comitato Organizzatore. Nel 1953 realizza il fonte battesimale in bronzo con il “Buon Pastore” per la Chiesa lucchese di S. Pietro Somaldi e partecipa al Concorso Nazionale per il Monumento a Pinocchio. Nel 1957 esegue un altorilievo in bronzo raffigurante “L'incredulità di S. Tommaso”, posto nella lunetta sulla sommità del portale dell'omonima chiesa lucchese del quartiere di Pelleria, dove già aveva lavorato nel primo Dopoguerra. È morto a Lucca il 24 novembre 1975. La documentazione relativa alla sua attività, alcune opere e numerosi bozzetti sono in gran parte conservati presso gli eredi dell’artista.
Errore nella query SELECT * FROM Formazione where id_artista = 118