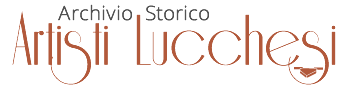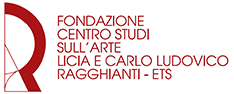Chini Galileo stampa la scheda 
Firenze, 02/12/1873

| Cognome | Chini |
|---|---|
| Nome | Galileo |
| Luogo di nascita | Firenze |
| Data di nascita | 02/12/1873 |
| Luogo di morte | Firenze |
| Data di morte | 23/08/1956 |
| Pittore | 
|
| Scultore | 
|
| Incisore | 
|
| Decoratore | 
|
Biografia
Nasce a Firenze il 2 dicembre 1873 da Elio, sarto e suonatore di filocorno, e da Aristea Bastiani. Alla morte dei genitori, ed interrotti gli studi alla terza elementare, viene accolto come apprendista nella bottega dello zio paterno Dario, decoratore e restauratore di affreschi, che lo iscrive ai corsi della Scuola d’Arte di Santa Croce e con cui partecipa, nel 1889, ai restauri in S. Trinita a Firenze. Nel 1897, morto lo zio, gli succede nell'incarico dei vari cantieri di restauro a Prato, Siena e San Miniato, rilevandone anche la bottega. Nel frattempo pratica la pittura da cavalletto: nel 1896 invia un suo quadro alla prima Mostra fiorentina dell'Arte e dei Fiori; l'opera non viene però accettata perché "troppo decorativa" ed è esposta alla mostra dei rifiutati. Nel 1895 si iscrive alla libera Scuola del Nudo dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, che frequenta fino al 1897. Nel 1896-97 fonda la manifattura L’Arte della Ceramica in collaborazione con Giovanni Vannuzzi, Vittorio Giunti e Giovanni Montelatico, con cui partecipa alle Esposizioni Internazionali di Torino e Londra, vincendo due medaglie d’oro. Nel 1899 sposa Elvira Pascetti. Nel 1900 partecipa con le ceramiche all’Exposition Internazionale di Parigi ottenendo il Grand Prix. Riprende a frequentare la libera Scuola fino al 1902 e non smette di praticare la pittura di cavalletto: di questo periodo restano due ritratti della moglie, databili al 1899, e l’opera “La quiete”, con cui partecipa per la prima volta alla Biennale di Venezia (1901). A tale manifestazione partecipa anche in seguito: nel 1903, anno in cui cura l’allestimento e la decorazione del padiglione toscano, nel 1905 e nel 1907, quando realizza la sala "L'arte del Sogno" in collaborazione con Plinio Nomellini e Edoardo De Albertis. Nel 1909 riceve l'incarico di affrescare la sala della cupola della Biennale con i periodi più importanti della civiltà e dell'arte (opera coperta nel 1936 da Giò Ponti in occasione della ristrutturazione l'edificio). Nel 1904 promuove con Ludovico Tommasi la Secessione della Promotrice fiorentina e, nello stesso anno, abbandona l’Arte della Ceramica per fondare, nel 1906, in società con i cugini Chino e Pietro, la Manifattura Fornaci S. Lorenzo – Chini, di cui diviene direttore artistico, aggiungendo alla tradizionale produzione di vasi e oggetti decorativi, quella di vetrate d'arte e piastrelle. Parallelamente realizza numerosi cicli decorativi, sia su committenza pubblica che privata, tra cui la sistemazione del padiglione italiano all'Esposizione Universale di Bruxelles (1910) e la partecipazione alle esposizioni celebrative del 1911 a Roma, Torino, Firenze. Nel 1908 intraprende l’attività di scenografo, realizzando le scene per la “Maschera di Bruto” di Sem Benelli. Nel 1909 prepara le scene, i costumi e i manifesti per la réclame della prima, all'Argentina di Roma, della “Cena delle beffe” e cura le scene per il “Sogno d'una notte di mezza estate”; nel 1910 esegue le scene per “L'Amore dei tre re”, sempre del Benelli, e per “L'Orione” di Ercole L. Morselli. Di rilievo anche la sua azione nel campo della grafica, della cartellonistica e dell’illustrazione. Ad attestarne la fama vennero gli incarichi ufficiali di insegnamento: nel 1908 gli viene assegnata la cattedra per le arti decorative pittoriche all'Accademia di Belle Arti di Roma e nel 1920 quella di decorazione pittorica all'Accademia di Firenze. Nel 1910 riceve l'incarico da parte del re del Siam Chulalongkorn, impressionato dalla decorazione della cupola alla Biennale dell'anno precedente, di decorare il palazzo reale di Bangkok, allora in avanzata fase di costruzione ad opera di un gruppo di architetti ed ingegneri italiani, soggiornandovi per ben tre anni (dal 1911 al 1914, accetto un breve rientro in patria nel 1913). Tornato in Italia, tiene alla Biennale del 1914 una personale con quindici "Impressioni d'Oriente", un buon numero di vasi in ceramica e in grès e curò l'allestimento in stile liberty del salone centrale. Nel 1915 fa costruire la villa di Fosso dell'Abate, oggi Lido di Camaiore, che diviene la sua residenza prediletta e luogo di ritrovo di alcune personalità artistiche del tempo. Nel 1917 prende il via la collaborazione al teatro pucciniano per i diversi ambienti del “Trittico”, ma alcune divergenze impedirono che i bozzetti del “Tabarro” fossero accolti, e vennero utilizzate solo le scene del “Gianni Schicchi” (in prima al Metropolitan di New York nel 1918). Nel dopoguerra, in occasione della Biennale del 1920, presenta tre dipinti e cura la decorazione pittorica del salone centrale e realizza numerose decorazioni a nella cittadina di Salsomaggiore. Nel 1922 realizza le decorazioni del Caffè Margherita e del Grande Hotel Excelsior di Viareggio, di cui due anni dopo è chiamato a dirigere la Commissione per il piano regolatore. Nel 1923 riprende la collaborazione con Puccini per la “Turandot”, del 1924 furono le scene per “Manon Lescaut”. In questi anni (tra il 1920 e il 1925 circa) si dedicò anche ad enormi pannelli per soffitti e pareti di navi, con episodi tratti dalla storia della marineria. Ininterrotto era stato il susseguirsi di riconoscimenti alle esposizioni internazionali, culminati nel 1925 con l'assegnazione, a Parigi dei due Grand Prix: uno per i materiali ceramici e uno per la produzione di vasi. Sul finire degli anni Venti si dedica prevalentemente ad una pittura di stampo naturalistico, di ascendenza post-macchiaiola, dipingendo nature morte, alcuni nudi e numerosi brani di paesaggio della Versilia, abbandonando momentaneamente il simbolismo di matrice secessionista. Nel corso degli anni Quaranta partecipa a diverse esposizioni, sia personali che collettive, in Italia e all’estero, tra cui la VII Mostra Estiva di pittura dedicata al paesaggio (1941) e alla Mostra d’Arte a Beneficio delle Forze Armate (1942) a Viareggio; nello stesso anno organizza con Orsi Pistelli e Arrighini la I Mostra d’Arte e Storia a Lido di Camaiore, dove ha una sala personale, alla IV Mostra degli Artisti Versiliesi a Seravezza, a Viareggio nella Bottega de’ Vàgeri; nel 1943 è di nuovo a Lucca all’Hotel Universo e ai Vàgeri di Viareggio. A partire dal 1950 è costretto a diminuire l’attività artistica a causa di un disturbo alla vista che lo condurrà alla cecità; continua però ad esporre in collettive e personali sia in Italia che all’estero. Muore a Firenze il 23 agosto 1956.
Il nucleo più consistente delle sue opere è a tuttora conservato presso gli eredi della famiglia nella villa di Lido di Camaiore. Per un approfondimento sul rapporto tra Chini e la Versilia cfr. Galileo Chini e la Toscana, a cura di Alessandra Belluomini Pucci, Glauco Borella, Milano, Silvana, 2010; La casa delle vacanze: Galileo Chini, opere 1900-1950, a cura di Fabio Benzi, Firenze-Siena, Maschietto e Musolino, 1998 e Giacomo Puccini e Galileo Chini: tra musica e scena dipinta, la favola cinese e altri racconti dal palcoscenico, Viareggio, La torre di legno, 2006.